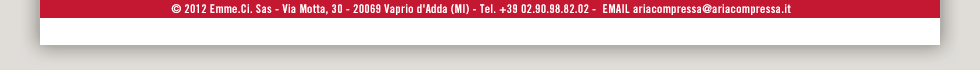Ingegner Massimo Rivalta
Si conclude con
quest'ultimo contributo la serie di articoli riguardanti la normativa PED in merito agli apparecchi in pressione. Considerata l'importanza dell'argomento, si è voluto fornire un elemento in più di valutazione per il lettore riguardo la nuova normativa, coinvolgendo in maniera diretta chi ha il compito di vigilare e far rispettare la legge sotto un profilo tecnico. Da qui l'intervista
che proponiamo ai nostri lettori.
Prendendo spunto
da una chiacchierata, che potrei definire informale, con l'Ingegner Diego Rosati, dell'ispesl
di Torino, e vista la consistenza degli argomenti trattati, ecco
nascere la nuova idea di realizzare una memoria informativa veramente
utile per chi approcci o direttamente interagisca con la PED.
Poiché la materia sollecitava interessanti suggerimenti di dialogo durante la conversazione, l'incontro, a poco a poco, si è trasformato
in uno stuzzicante contesto di domande e risposte.
Risultando impossibile riportare completamente i contenuti del colloquio,
per quantità di informazioni e approfondimenti, si è optato per un'impostazione della memoria un po' inusuale, ma sicuramente non priva di contenuti tecnici di particolare importanza, quali sono, appunto, quelli esposti nell'intervista.
La mia innata curiosità e la notevole preparazione dell'interlocutore hanno, così,
permesso di realizzare un documento che definirei di considerevole
interesse per gli addetti ai lavori.
Ho scoperto, in tal modo, un'altra faccia della PED. Cioè quei risvolti che spesso rimangono nascosti tra le righe di una normativa che comprende, oltre alla lungimiranza e competenza del legislatore, anche gli inevitabili "errori di gioventù" o, forse, paga pegno alla necessità di voltar pagina in maniera troppo repentina in un settore talmente tecnico e specifico qual è quello
degli argomenti considerati nella PED.
Nasce pertanto questa intervista, un inconsueto districarsi tra vecchi
articoli e nuove competenze raccontati con l'incedere narrativo di
una novella per fanciulli, ma ricca di significati tecnici e riferimenti
normativi.
Troverà, il lettore, leggendo queste righe, che non sempre la legge è ostica a chiunque non abbia competenze e titoli altisonanti, ma può essere fatta oggetto di osservazioni specifiche nel momento in cui chi le espone e le commenta riesce a dar prova di approfondita conoscenza e di abilità espositiva
adeguate.
Quali difficoltà
Ingegnere, quali sono
le effettive difficoltà incontrate, considerata la sua esperienza,
nell'applicazione della Direttiva PED da parte degli addetti ai lavori?
Le difficoltà che si presentano sono di diverso ordine. In primo luogo, manca
la capacità di prendere in considerazione tutto ciò che la Direttiva attualmente
identifica come attrezzatura, ma che, precedentemente, non era considerato "apparecchio
a pressione" dalla normativa nazionale.
Può illustrarci più chiaramente tale concetto?
E' difficile, per il fabbricante, rendersi conto che una tubazione, un accessorio
a pressione o un accessorio di sicurezza possano oggi essere commercializzati
solo dopo che per essi è stato predisposto un fascicolo tecnico, al pari
di quanto si fa per un recipiente o per un corpo caldaia.
Il caso di tubi e valvole
Facciamo un esempio
significativo per meglio entrare nel merito della questione: cosa
cambia, effettivamente, nel caso specifico, per una tubazione?
Nel
vecchio regime di omologazione nazionale, le tubazioni erano sostanzialmente
escluse
in blocco dalla sorveglianza dall'art.4 del RD 824 del 12 maggio 1927 (Ndr:
si veda, in proposito, la tabella riportata in questo articolo). Oggi,
il campo di esclusione è molto più limitato e, in generale, è passibile
dell'obbligo
di marcatura CE qualsiasi tubazione ubicata all'interno di una rete industriale
di servizio (valutati, ovviamente, PS e DN).
Possono essere gestite in
regime di "buona prassi costruttiva" tutte le tubazioni con DN inferiore
a 25, quando il contenuto ricade nel gruppo I (fluido pericoloso) e tutte
le tubazioni
con DN inferiore a 32 quando il contenuto ricade nel gruppo II (fluidi
non pericolosi). A valle di questa prima scrematura, sono possibili ulteriori
distinguo: ad esempio, se il fluido è un liquido poco volatile alla temperatura
di progetto TS (ovvero la sua tensione di vapore è inferiore a 1,5 bar
assoluti), non occorrono, in realtà, particolari accorgimenti fino al DN
200. Al di fuori di valori di DN molto piccoli, superiori a 25 o 32 appunto, è comunque
opportuno procedere alla valutazione caso per caso del prodotto che si
intende realizzare, sulla base delle tabelle dell'allegato II al D.Lgs.
93/2000 (per le tubazioni, le tabelle sono quelle dalla 6 alla 9).
Quali sono i potenziali rischi cui si
va incontro se da questa verifica risulta che la tubazione ricade
in categoria di rischio?
Sarà comunque indispensabile
applicare uno dei moduli di valutazione della conformità, formalizzando
le procedure di progettazione e di fabbricazione e la descrizione del
funzionamento dell'attrezzatura all'interno di un fascicolo tecnico.
Il fabbricante potrà,
tuttavia, procedere in autonomia se la categoria di rischio individuata è la
I, applicando il modulo A, mentre dovrà richiedere l'intervento di un
Organismo Notificato che presieda alla valutazione del fascicolo tecnico
per le categorie
superiori; sarà altresì necessario, in tal caso, incaricare lo stesso
o un altro Organismo Notificato, oppure una Entità Terza Riconosciuta,
affinché qualifichi
i procedimenti di giunzione permanente impiegati e i relativi operatori.
Dovrà, infine, essere predisposta la documentazione relativa all'attestazione
verso terzi delle valutazioni eseguite (dichiarazione di conformità)
e il manuale d'uso, installazione e manutenzione da fornire all'utilizzatore.
Poniamo il caso di un fabbricante particolarmente
zelante. Potrebbe egli stesso provvedere a tutto questo anche se
la tubazione che produce risulta trovarsi
sulle tabelle al di sotto della I categoria?
La procedura sopra esemplificata
si applica per attrezzature a pressione che devono essere marcate CE
per poter essere commercializzate, cioè che ricadono in una delle categorie
di rischio. In questo ambito, è consentita al fabbricante la massima
libertà nella
scelta del modulo di valutazione di conformità: nulla vieta di applicare
un modulo per attrezzature di IV categoria a un'attrezzatura che risulta
essere di I. Viceversa, non si deve assolutamente cercare di pervenire
alla marcatura CE di una attrezzatura che non ricade in nessuna delle
categorie di rischio e che, pertanto, può essere immessa sul mercato
senza che ne sia dichiarata la conformità alla Direttiva.
Quanto detto
a proposito delle tubazioni si può ripetere identicamente anche
per un accessorio a pressione, ad esempio per una valvola di intercettazione?
Si. Anche qui la valutazione deve essere fatta caso per caso. Una valvola
di intercettazione non risponde necessariamente all'obbligo previsto dalla
Direttiva di applicazione di una delle procedure di valutazione della conformità,
e il fabbricante può, in tal caso, limitarsi all'applicazione dei codici
di buona tecnica in uso. E' importante, però, prendere in considerazione
la possibilità che
la valvola si trovi almeno nella prima categoria di rischio. Se, ad esempio,
vogliamo valutare una valvola su tubazione per Gpl (gas pericoloso con
PS 17,65 bar), vedremo che una valvola da 1 pollice ricade in I categoria
di
rischio
e una analoga valvola da 2 pollici è già in II categoria. Una valvola dello
stesso diametro, impiegata però su una tubazione contenente gas non pericoloso,
come l'aria, alla stessa pressione di progetto o a valori superiori, sarà invece
in I categoria.
Analisi dei rischi
Superata questa fase
di presa di coscienza del problema, quali altre difficoltà incontra
in generale il fabbricante?
Le difficoltà per il fabbricante spesso
riguardano, a questo punto, l'individuazione di supporti validi
per lo sviluppo dell'analisi
dei rischi prevista dalla Direttiva. E' da considerare, a tal proposito,
che, per molti prodotti, non sono ancora disponibili, a livello
europeo, le norme armonizzate di progettazione, fabbricazione ed
esercizio che
dovrebbero costituire riferimento certo in questo senso. E' opportuno,
pertanto, mantenersi continuamente aggiornati sulla situazione,
in quanto è frequente
il caso di un progetto di norma che subisce l'avvallo e diventa
EN utilizzabile.
Altro problema è rappresentato dallo scambio delle
informazioni tra fabbricante e utilizzatore circa le condizioni
di esercizio dell'attrezzatura,
spesso troppo stringato. Il risultato che ne segue può essere
la mancata identificazione di alcuni pericoli, oppure una scarsa
attivazione
di misure preventive
nei confronti del rischio, con manuali di istruzioni che, di fatto,
demandano all'utilizzatore molte valutazioni che dovrebbero essere
già risolte
a livello di fascicolo tecnico.
Proprio a questo
proposito, infatti, la PED introduce il concetto di insieme.
L'insieme è, in effetti, un'entità che dovrebbe essere applicata ogni
volta che un fabbricante è chiamato a fornire un impianto, o
una sezione di questo, come tutto integrato e funzionale.
L'obiettivo
dell'insieme è quello
di innalzare l'orizzonte dell'analisi di rischio al di sopra dei
confini della singola attrezzatura, consentendo una valutazione
integrata delle
interazioni
tra
i diversi componenti assemblati nell'impianto. Il modulo di valutazione
di conformità per l'insieme garantisce che ciascuna delle attrezzature
all'interno
di esso è stata oggetto di valutazione di conformità e che anche
i rischi derivanti dall'assiemaggio sono stati valutati a cura
del fabbricante.
Molto spesso,
però, si verifica il caso in cui il fabbricante non fornisce il
modulo di insieme, oppure l'impianto è oggetto di fornitura ripartita
tra differenti fabbricanti. Come si deve agire in questi casi?
Allora
il discorso
si sposta
dal fronte delle difficoltà per i fabbricanti a quello dei problemi
per gli utilizzatori. La PED individua come alternativa all'insieme
il cosiddetto "assemblaggio
sotto responsabilità dell'utilizzatore". Questo concetto corrisponde
a una configurazione realizzata all'atto dell'esercizio a partire da
attrezzature che singolarmente sono già state oggetto di commercializzazione
(e quindi, se del caso, di marcatura CE). Rispetto a questo assemblaggio,
la PED,
in quanto norma di costruzione e
non di esercizio, non si esprime, demandando la valutazione dell'operato
dell'utilizzatore
alle singole legislazioni nazionali. Ricordiamo, a questo punto, che
per l'Italia
la suddetta legislazione è in fase di revisione e che un decreto sarà presto
emanato a riordino del settore. E' certo, comunque, che l'utilizzatore
sarà chiamato
a rispondere, in maggiore o minore misura, e probabilmente di fronte
a soggetti verificatori privati, dei potenziali rischi introdotti dall'accoppiamento
dei diversi componenti, fornendo evidenza documentale dei risultati
delle valutazioni
eseguite. Anche le operazioni di controllo della messa in servizio
saranno conseguentemente più onerose per gli assemblaggi sotto responsabilità dell'utilizzatore:
si consideri anche l'aspetto meramente burocratico, che prevede che
l'utilizzatore
inoltri presso i soggetti pubblici Ispesl e Asl una dichiarazione di
messa in servizio
per ogni singola attrezzatura, a fronte dell'unica dichiarazione prevista
nel caso dell'insieme.
Abbiamo precedentemente
considerato l'esempio
delle tubazioni. Lo stesso concetto viene applicato anche per un
tratto di tubazione?
Il decreto porrà opportuni
limiti inferiori al di sotto dei quali non sarà necessario provvedere
alla dichiarazione di messa in servizio e alle successive verifiche,
che non
avrebbero significatività alcuna:
si pensi al caso degli estintori d'incendio portatili. In questo
contesto, le tubazioni isolate saranno oggetto di "condono" almeno
per quanto riguarda i diametri più piccoli. Molte altre tipologie
di esclusione potrebbero venire recuperate dalla vecchia norma
sull'esercizio, non
per forza con gli stessi limiti di applicazione. Sottolineiamo
che tali esclusioni non
svincolano
l'attrezzatura
dagli obblighi della Direttiva, ai fini della marcatura CE, che
coinvolgeranno comunque la precedente
fase di costruzione.
Si può affermare, quindi, che, in termini
pratici, il modulo di insieme minimizza il rischio residuo a carico
dell'utilizzatore?
E' senz'altro così. I problemi dell'assiemaggio
possono essere molteplici e non trascurabili: si pensi al caso di
un impianto
per fluido caldo
in cui la commessa dei recipienti viene affidata a un fabbricante
e la commessa
delle tubazioni che li collegano l'uno all'altro a un secondo
fabbricante. Atteso che sia i recipienti sia le tubazioni
saranno senza dubbio
forniti all'utilizzatore completi di dichiarazione di conformità CE
per la categoria di pertinenza, qual è il soggetto in grado
di valutare compiutamente i rischi introdotti dalle sollecitazioni
alle connessioni indotte dalla
dilatazione
termica delle linee, nei tratti rigidi? Se la comunicazione
tra
i fornitori non è correttamente gestita, è verosimile che
l'utilizzatore
venga identificato quale titolare di queste valutazioni,
in quanto la progettazione
complessiva
dell'impianto è formalmente a suo carico. Il rischio residuo
a questo punto è perlomeno
da prendere in esame, senza contare il fatto che una valutazione "a
posteriori" può condurre
a dispendiosi interventi correttivi su attrezzature a questo
punto già fabbricate.
Il tema delle "riparazioni"
Finora abbiamo
parlato del nuovo trascurando il problema dell'esistente.
I vecchi apparecchi Ispesl già in esercizio diventano
delle potenziali "mine
vaganti", nel senso che, quando fosse necessario riportarli
in officina per porre rimedio a un problema su una parte
in pressione,
il regime
PED creerebbe
insormontabili difficoltà formali?
No, esiste una circolare
Ispesl che si pronuncia sulla riparazione o modifica
degli apparecchi a pressione corredati
del vecchio
libretto matricolare.
Tali operazioni vengono realizzate secondo la norma in
vigore all'atto
della costruzione, per cui l'Ispesl rimane la struttura
di riferimento per l'approvazione
degli interventi e per le verifiche sull'apparecchio
al termine delle operazioni di "restauro". E' implicito
che, nel caso di modifiche, l'entità delle
stesse non potrà trasformare l'apparecchio d'origine
in un qualcosa di totalmente diverso, assimilabile a
una nuova
attrezzatura, perché in
tal caso è previsto
che la norma di riferimento sia la Direttiva PED.
E sul futuro
delle attrezzature PED che oggi subiscono il "varo" che
cosa ci si deve aspettare?
Dal punto di vista del fabbricante,
riparazioni e
modifiche su attrezzature costruite in regime di PED dovranno,
del pari, essere gestite
secondo la Direttiva. Per quanto riguarda l'utilizzatore,
le verifiche di messa in servizio costituiranno una parte
del
contenuto del Decreto
di armonizzazione
della norma sull'esercizio; l'altro importante aspetto
che il testo normativo dovrà regolamentare sarà la periodicità delle
verifiche di riqualificazione durante l'esercizio.
Potrebbe fornire ai nostri lettori qualche
anticipazione in merito?
Le categorie di attrezzature più "fortunate" saranno
i recipienti e le tubazioni per liquidi, per i quali
potrebbe
non essere
prevista alcuna
verifica. Anche
per le verifiche periodiche ci si dovrà, invece,
rassegnare a gestire le tubazioni a più elevata categoria
di rischio alla stregua dei recipienti, con obbligo
di impiego
a intervalli predefiniti di
metodologie di controllo
non distruttivo. Per i recipienti, l'innovazione
sarà costituita
da una gestione differenziata degli intervalli tra
due successive riqualificazioni
in base
alla categoria di rischio del prodotto. |