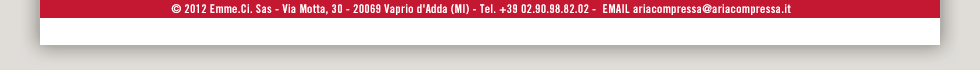Massimo Rivalta - Ingegnere
Tipi di impianti di distribuzione trattati nella norma. Centrali di alimentazione degli impianti. Reti di distribuzione. Sistemi di controllo, monitoraggio e allarme. Installazione delle reti di distribuzione. Modifiche e collegamenti a reti di distribuzione esistenti (ampliamenti). Prove, accettazione e certificazione.
Questi gli aspetti trattati nell'articolo relativamente a un importante contenuto normativo, legato, com'è, al tema della salute.
La direttiva 93/42/Cee
riguardante i dispositivi medici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità Europee il 12 luglio 1993, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore a partire dal 14 giugno 1998. Gli impianti per la distribuzione di gas medicali e del vuoto rientrano, in virtù di tale decreto, nella categoria dei dispositivi citati e sono, quindi, soggetti alle prescrizioni della direttiva dell'Unione Europea ai fini della marcatura CE.
Ciò significa che la progettazione e la realizzazione di un impianto per la distribuzione di gas medicali e del vuoto possono essere effettuate esclusivamente da aziende che abbiano subito un particolare iter di certificazione controllato da Organismi notificati nell'ambito dell'Unione Europea.
Il Cen, su incarico della Commissione europea e dell'Associazione europea per il libero commercio, ha emanato la norma EN 737-3 che supporta le richieste essenziali della direttiva 93/42/Cee.
Quindi, gli impianti realizzati in conformità alla Norma europea EN 737-3 soddisfano anche i requisiti essenziali della direttiva ricordata. La dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90 è da considerarsi ancora in vigore, pur essendo superata da quella CE, che garantisce il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva 93/42/Cee mediante la conformità alle Norme armonizzate Uni EN 737-3 e Uni EN 737-2. Pertanto, si può affermare che un impianto marcato CE come dispositivo medico può essere dichiarato anche conforme ai requisiti della legge 46/90.
Cosa stabilisce
La
direttiva stabilisce che, a partire dal 16 giugno 1998, i fabbricanti
di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti
conformi alla normativa comunitaria e recanti la marcatura CE. I
dispositivi medici su misura, cioè quelli fabbricati appositamente
su prescrizione medica e destinati a essere utilizzati per un determinato
paziente (quale, ad esempio, una protesi dentaria) non devono recare
la marcatura CE.
La normativa entra in vigore contemporaneamente
in tutta Europa e interessa i dispositivi medici di ogni genere:
siringhe, termometri, valvole cardiache, cateteri e apparecchiature
elettromedicali, Tac, RM, camere iperbariche ecc.
La classificazione dei dispositivi medici riguarda migliaia di prodotti e
numerose categorie di fabbricanti, tra i quali anche gli odontotecnici,
i tecnici ortopedici e altre categorie professionali.
Per quanto
concerne gli ottici, con circolare del 12 giugno è stato chiarito
che tale categoria non rientra fra quelle assoggettate alla disciplina
del Dlgs 46/97. I fabbricanti sono responsabili della progettazione,
della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei dispositivi
immessi in commercio. Essi dovranno seguire specifiche procedure
per la valutazione della conformità del prodotto alla direttiva,
differenziate in base al rischio che il dispositivo comporta sul
corpo umano. I rischi correlati al dispositivo medico dovranno essere
ridotti al minimo e gli utilizzatori dovranno essere informati su
eventuali rischi residui.
Gas medicali
Particolarmente
di nostro interesse è la parte della norma riguardante gli
impianti di distribuzione dei gas medicali.
Si è abituati a considerare
l'ospedale
come una zona franca, in cui tutto funziona perfettamente, in cui l'igiene è al
primo posto al pari della capacità e della professionalità di medici, infermieri
e personale ospedaliero.
Ma, in realtà, quante volte è sorto il dubbio
che, anche all'interno di queste strutture (all'apparenza perfettamente
funzionanti), possa celarsi l'imponderabile o, più semplicemente, la trascuratezza
di impianti non del tutto efficienti? E chi garantisce o cerca di garantire
la funzionalità di
enti così complessi e di quali strumenti dispone affinché ciò sia realizzabile?
A cosa corrisponde la qualità negli ospedali? La qualità negli ospedali
si misura anche in termini di sicurezza e prestazione che una simile infrastruttura
dovrebbe essere in grado di garantire, per erogare correttamente tutti
i
servizi richiesti. Ci si riferisce, ad esempio, a tutte le apparecchiature
installate in tali luoghi, nonché all'impiantistica prevista e utilizzata
per il funzionamento di tutti gli strumenti e le apparecchiature installate
e destinate alla cura dei pazienti.
Molti sono ancora oggi gli incidenti
causati da un cattivo funzionamento degli impianti che devono distribuire
correttamente, nelle corsie o nelle sale operatorie, ossigeno, protossido
di azoto e altri gas, utilizzati dalle sofisticate attrezzature, necessari
o, addirittura, vitali a ogni attività di cura o di intervento.
Negli ospedali moderni diventa, quindi, sempre più importante considerare
gli impianti di distribuzione dei gas medicali, di aria per strumenti chirurgici
o altro, come uno degli elementi chiave per elevare al massimo il livello
di sicurezza e di prestazione della struttura, a garanzia di un servizio
che deve tendere all'eccellenza.
A questo proposito, è stata studiata
in Europa una specifica norma tecnica chiamata Uni EN 737-3 "Impianti di
distribuzione dei gas medicali - Impianti per gas medicali compressi e
per vuoto".
Questa norma considera i requisiti fondamentali per l'installazione, il
funzionamento, le prestazioni, la documentazione, le prove e l'accettazione
degli impianti
di distribuzione dei gas medicali compressi e del vuoto, generalmente installati
negli ospedali e nei centri di cura, per garantire la sicurezza dei pazienti.
Un impianto di distribuzione è, secondo la norma, "...un sistema completo
che comprende la centrale, la rete di distribuzione e le unità terminali
nei punti dove i gas medicali o l'evacuazione dei gas anestetici possono
essere richiesti".
Tra gli obiettivi della norma vi è quello di assicurare che gli impianti
di distribuzione dei gas medicali contengano esclusivamente i gas per i
quali sono stati previsti. Può sembrare banale, ma casi di incidenti in
ospedale, dovuti al cattivo funzionamento degli impianti di distribuzione
o, addirittura,
di somministrazione di gas inappropriati ai pazienti, non sono così rari.
La Uni EN 737-3, inoltre, richiede l'utilizzo di componenti gas-specifici
per la costruzione delle unità terminali e per tutti i raccordi utilizzati
dall'operatore, proprio con il fine di ridurre errori e danni ai pazienti
o cose. Ad esempio, le "prese" fissate nelle travi testaletto, e dove si
collegano alcune apparecchiature elettromedicali destinate a fornire ai
pazienti i relativi gas medicinali, devono essere facilmente identificabili
dall'operatore
e devono essere costruite in modo tale da evitare ogni errata connessione
con prese che erogano gas diversi da quelli previsti. Questi aspetti non
sono per niente trascurabili, visto che influenzano direttamente le funzioni
vitali dei pazienti.
La Uni inoltre, indica che ogni singola rete deve
essere sottoposta a prova e deve essere certificato che contiene solo il
gas per
il quale è stata prevista.
La Uni EN 737-3 assicura che l'impianto di distribuzione eroghi con continuità il
corretto gas medicale nella rete dell'ospedale.
Tipi di impianti
considerati
La Uni EN 737-3 si applica unicamente agli impianti che distribuiscono
nelle reti dell'ospedale i seguenti gas: |
| • |
ossigeno; |
| • |
protossido di azoto; |
| • |
aria respirabile; |
| • |
anidride carbonica; |
| • |
miscela ossigeno/protossido di azoto [50:50 (% V/ V )]; |
| • |
aria per alimentare strumenti chirurgici; |
| • |
azoto per alimentare strumenti chirurgici; |
| • |
e agli impianti di distribuzione per "vuoto". |
|
Nella
norma, sono indicati i requisiti fondamentali per le centrali di alimentazione,
per la rete di distribuzione, per i sistemi di controllo, di monitoraggio
e di allarme e per la non intercambiabilità fra i componenti delle
differenti reti di distribuzione dei gas.
Esaminiamoli punto per punto.
Centrali di alimentazione
Il
dimensionamento dello stoccaggio della centrale e della sua riserva
deve essere
stimato in base all'uso e alla frequenza di approvvigionamento del
gas da parte del fornitore.
Le dimensioni delle sorgenti di alimentazione primaria, secondaria e di riserva
dovrebbero essere definite dalla direzione dell'ospedale in collaborazione
con il fabbricante e con il fornitore del gas.
Anche il numero di
bombole da tenere di riserva dovrebbe essere definito. Per lo stoccaggio
delle
bombole, dovrebbe essere previsto un apposito locale. Tutte le centrali
devono garantire la continuità di erogazione nelle normali condizioni
di utilizzo e in condizione di singolo guasto (concetto spiegato
nella Uni EN).
Secondo la norma, la centrale deve essere composta da: |
| • |
gas in bombole; |
| • |
liquido non criogenico in bombole; |
| • |
liquido criogenico in contenitori mobili; |
| • |
liquido criogenico in contenitore(i) fisso(i); |
| • |
compressore(i) di aria; |
| • |
miscelatore; |
| • |
pompa del vuoto. |
|
La Uni EN 737-3 entra nel dettaglio per ogni componente della centrale.
Nella norma, inoltre, si trovano le indicazioni riguardanti tutti i riduttori di pressione installati all'interno delle centrali, i quali devono essere in grado di controllare la pressione di rete ai livelli specificati nella norma stessa.
Reti di distribuzione
Tranne
che per la rete di distribuzione del vuoto, tutte le sezioni delle
reti di distribuzione dei gas medicali devono resistere a una
pressione di 1,2 volte quella massima che può essere applicata a ogni
sezione in condizione di singolo guasto. La pressione nominale di distribuzione
deve essere entro i limiti specificati nella norma. Nello stesso ospedale,
possono essere distribuiti diversi gas a pressioni nominali di distribuzione
differenti. In locali quali quelli per terapie intensive e nelle sale
operatorie, possono essere installati mezzi per il controllo della
pressione del protossido di azoto da parte della pressione dell'ossigeno,
in modo da mantenere la pressione del protossido di azoto minore di
quella dell'ossigeno. La norma prevede l'utilizzo di collegamenti flessibili,
usati come componenti delle reti di distribuzione: ad esempio, per
isolare dalle vibrazioni, per compensare i movimenti degli edifici
e i movimenti relativi delle tubazioni. Questi collegamenti flessibili
per bassa pressione sono normalmente usati nella rete di distribuzione: |
| • |
per alimentare in emergenza una rete di distribuzione; |
| • |
come parte di apparecchiature permanentemente collegate quali bracci e pensili. |
|
| |
Sistemi di controllo
monitoraggio e allarme
I sistemi di monitoraggio e di allarme hanno
tre funzioni principali con differenti scopi, cioè allarmi operativi,
allarmi operativi di emergenza e allarmi clinici di emergenza. |
| - |
Lo scopo degli allarmi operativi è di notificare, al personale tecnico, che una o più sorgenti all'interno della centrale di alimentazione non è più utilizzabile e che è richiesto un intervento. |
| - |
Gli allarmi operativi di emergenza indicano una pressione anomala nella rete di distribuzione e potrebbero richiedere un intervento di emergenza da parte del personale tecnico. |
| - |
Gli allarmi clinici di emergenza indicano una pressione anomala nella rete di distribuzione e potrebbero richiedere un intervento di emergenza da parte del personale clinico. La norma dà ampio spazio a tutti questi aspetti, richiamando anche l'applicazione di altre norme tecniche. |
|
| |
Installazione
delle reti distributive
Le reti di distribuzione devono essere utilizzate
solo per la cura del paziente. Nessuna connessione deve essere realizzata
all'interno della rete per altri usi, tranne che per la rete dell'aria
compressa, per la quale eventuali estensioni sono previste in accordo
con i requisiti appropriati applicabili della Uni EN 737-3. Ad esempio,
se viene installata una camera iperbarica per uso medico, può essere
necessario prevedere una rete di distribuzione separata, idonei dispositivi
di controllo della pressione e della portata e mezzi appropriati per
prevenire il riflusso.
Le reti di distribuzione e gli impianti elettrici
devono essere posti in compartimenti separati o essere separati da
più di 50 mm.
La rete di distribuzione deve essere collegata alla rete
di terra il più vicino possibile al punto di ingresso nell'edificio.
Le reti di distribuzione non devono essere utilizzate per collegare a terra le
apparecchiature elettriche. Esse, inoltre, devono essere protette da
danni fisici, dovuti, per esempio, allo spostamento di apparecchiature
portatili, carrelli, barelle ecc. nei corridoi o in altri luoghi. Reti
di distribuzione non protette non possono essere installate in aree
pericolose, per esempio dove sono immagazzinati materiali infiammabili.
Dove non si può evitare l'installazione delle reti di distribuzione in tali luoghi,
esse devono essere dotate di protezioni per prevenire, in caso di perdite, fuoriuscite
di gas medicali all'interno dei locali.
La norma Uni EN 737-3 richiama l'attenzione
ai regolamenti nazionali riguardanti gli edifici e le norme antincendio che devono
essere tutti applicati.
Se le reti di distribuzione dei gas medicali sono posizionate nello stesso tunnel,
trincea o condotto, singolarmente, con reti di altri servizi o con reti di distribuzione
di altri fluidi o gas, il potenziale pericolo derivante da tale situazione deve
essere valutato in accordo con la norma Uni EN 1441 "Dispositivi medici - analisi
dei rischi".
La valutazione del rischio deve considerare che una fuga non rilevata (per esempio
da un allarme o da ispezioni periodiche) deve essere considerata condizione normale
e non condizione di singolo guasto. Le reti di distribuzione non devono essere
installate nei vani ascensore.
Le valvole di intercettazione non devono essere
installate dove un'eventuale fuga possa essere causa di accumulo di gas, per
esempio in cavità stagne. Danni dovuti al contatto con materiale corrosivo devono
essere minimizzati con l'uso di materiale non metallico e impermeabile applicato
sulla superficie esterna dei tubi nelle aree dove può avvenire il contatto. Si
deve tenere conto dell'espansione e della contrazione delle reti di distribuzione.
Tutte le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere installate in luoghi
nei quali non sono esposte a temperature minori di 5 °C rispetto al punto di
rugiada del gas alla pressione di distribuzione. Non è necessario installare
le reti di distribuzione con pendenza per poter scaricare la condensa.
Interventi su reti
esistenti
In molti casi, si è in presenza di ampliamenti delle aree
ospedaliere con consistenti interventi strutturali. Vediamo come viene
affrontato l'argomento secondo la
normativa.
La Uni EN 737-3 richiede una valutazione della portata della rete
di distribuzione esistente, che deve essere sufficiente a soddisfare la richiesta
dell'ampliamento previsto. Il collegamento finale all'ampliamento deve essere
effettuato su un impianto alla volta, al fine di ridurre il rischio di interconnessione.
Tutti gli altri impianti devono rimanere alla normale pressione di distribuzione.
Il posizionamento di tale collegamento dovrebbe essere definito con attenzione,
per minimizzare i problemi di accesso durante l'installazione e le prove.
Quando
si deve effettuare un ampliamento di una rete esistente, il punto di partenza
della nuova tubazione deve essere provvisto di una valvola di intercettazione
di area per isolarla da quella esistente; fa eccezione il caso in cui sia possibile
utilizzare una valvola di intercettazione di area già esistente.
Prove, accettazione
e certificazione
Per assicurare che ogni intervento sia stato eseguito
a regola d'arte, bisogna
prevedere delle prove di accettazione e arrivare alla certificazione.
Scopo
delle prove e dell'accettazione degli impianti di distribuzione dei gas medicali è di
verificare che tutti gli aspetti connessi con la sicurezza e le prestazioni
dell'impianto siano stati rispettati.
Nella norma Uni EN 737-3 sono riportati
esempi di come
effettuare la prova e l'accettazione.
Tutte le prove effettuate dopo il completamento dell'installazione dovrebbero
essere eseguite dall'installatore sotto la sorveglianza di una persona autorizzata
e competente nel settore delle prove degli impianti di distribuzione dei
gas medicali, che dovrebbe certificare i risultati al proprietario (dell'impianto).
L'autorizzazione può essere fornita nell'ambito del sistema di qualità del
fabbricante, certificato conforme alle appropriate parti delle norme sui
sistemi qualità.
I risultati delle prove, che mostrano i dettagli degli impianti e delle aree
sottoposte a prova, dovrebbero far parte della documentazione dell'ospedale
(regolarmente archiviata). La 737-3 entra nel dettaglio di tutte le prove
e controlli previsti.
Le prove si dividono in: |
| • |
prove dopo l'installazione delle reti di distribuzione con i blocchi di base di tutte le unità terminali montati, ma prima di chiudere le tracce, e sono: |
| |
| - |
prova
di resistenza meccanica; |
| - |
prova di tenuta; |
| - |
prova di interconnessione e di ostruzione; |
| - |
controllo della marcatura e dei supporti della rete di distribuzione; |
| - |
controllo visivo per garantire che tutti i componenti installati in questa fase siano conformi alle specifiche di progetto; |
|
|
| |
| • |
e prove e procedure dopo il completamento dell'installazione e prima dell'uso dell'impianto prova di tenuta, che sono: |
| |
| - |
prova di tenuta e prova delle valvole di intercettazione per efficienza di chiusura e identificazione delle aree servite; |
| - |
prova di interconnessione; |
| - |
prova di ostruzione; |
| - |
prova delle unità terminali e dei raccordi Nist per funzionamento meccanico, gas-specificità e identificazione; |
| - |
prova delle prestazioni dell'impianto; |
| - |
prova delle valvole di sovrappressione; |
| - |
prova funzionale di tutte le sorgenti; |
| - |
prove dei sistemi di controllo, monitoraggio e allarme; |
| - |
spurgo con il gas di prova; |
| - |
prova di contaminazione da particelle solide della rete di distribuzione; |
| - |
riempimento con il gas specifico; |
| - |
prova di purezza dell'aria prodotta da compressori; |
| - |
prova di identificazione del gas. |
|
|
| |
Prima di poter utilizzare gli impianti di distribuzione dei gas medicali, si deve certificare, per iscritto, che i requisiti specificati nella norma sono stati rispettati.
Il fabbricante è tenuto a certificare che tutti i disegni e i manuali specificati nel punto 13 (informazioni da fornire) della Uni EN 737-3 sono stati consegnati al proprietario. Quando tutte le prove sono state positivamente completate, devono essere rimosse tutte le etichette fissate alle unità terminali durante la costruzione.
Gli impianti di distribuzione dei gas medicali sono considerati dei dispositivi medici e, come tali, devono rispondere alle prescrizioni della direttiva 93/42/Cee.
La norma Uni EN 737-3 ha un legame diretto con tale direttiva, in quanto è una norma armonizzata e, se seguita per la progettazione, la costruzione e l'installazione degli impianti di distribuzione dei gas medicali, conferisce presunzione di conformità a tale direttiva (e, quindi, anche alla legge), con il vantaggio di avere un documento tecnico che dice esattamente come "fare" un impianto di distribuzione conforme alla regola dell'arte richiesta.
Ma se, da una parte, sussistono, come abbiamo verificato, le condizioni per definire "in sicurezza e qualità" un ospedale da un punto di vista impiantistico, ampliando il discorso si può dire che esistono e sono definiti dei requisiti generali minimi per i presidi ospedalieri, sia strutturali sia tecnologici generali.
Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:
|
| • |
protezione antisismica; |
| • |
protezione antincendio; |
| • |
protezione acustica; |
| • |
sicurezza elettrica e continuità elettrica; |
| • |
sicurezza antinfortunistica; |
| • |
igiene dei luoghi di lavoro; |
| • |
protezione dalle radiazioni ionizzanti; |
| • |
eliminazione della barriere architettoniche (in particolare, tutti i presidi devono soddisfare al requisito dell'accessibilità); |
| • |
smaltimento dei rifiuti; |
| • |
condizioni microclimatiche; |
| • |
rispetto del divieto di fumo; |
| • |
impianti di distribuzione dei gas; |
| • |
materiali esplodenti; |
| • |
attrezzature biomediche e sanitarie; |
| • |
manutenzione degli edifici e degli impianti. |
|
| |
In merito a tali problematiche, si fa riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.
Un'attività sicuramente complicata gestire un ospedale o un presidio di rilevante importanza, anche considerando la mole di lavoro organizzativo ed effettivo che sta dietro a simili realtà. Ecco che, allora, nonostante l'ospedale non rappresenti un luogo di svago, dovremmo cercare di essere obiettivamente critici nei confronti di chi all'interno opera con professionalità, senza per questo fare di ogni erba un fascio.
|
|