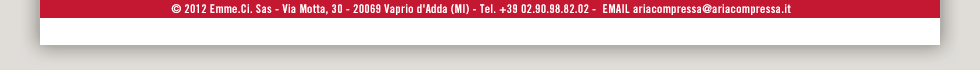Massimo Rivalta - Ingegnere
I gas costituiscono,
da lungo tempo, un consolidato aiuto per la professione medica e la
tecnologia
continua a offrire nuove soluzioni e nuove opportunità di
applicazione per i gas farmaceutici.
I gas assistono la respirazione e l'anestesia, consentono agli scienziati
lo studio delle patologie polmonari e del sistema cardiovascolare, sono
strumenti essenziali nel processo diagnostico e in crioconservazione
e, quando necessario, possono essere utilizzati per la taratura di delicati
dispositivi medici di misurazione. L'azoto liquido e l'elio sono da tempo
utilizzati per la risonanza magnetica.
In poche parole, i gas rappresentano una parte essenziale della moderna
medicina.
Dal pronto soccorso alla sala operatoria, dal centro di risonanza magnetica
ai laboratori clinici, fino alle degenze, si deve garantire la sicurezza
di continuità nella fornitura di gas farmaceutici attraverso la
realizzazione di centrali di erogazione e impianti di distribuzione progettati
da uno staff qualificato e attraverso una serie di servizi ad alto valore
aggiunto.
Gas medicinali
Sono definiti “medicinali” dalla Farmacopea ufficiale quei
gas classificati come farmaci, fisiologicamente attivi, impiegati in
vivo per diagnosi mediche o per riattivare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche.
Essi sono:
• Ossigeno;
• Azoto;
• Aria per respirazione;
•
Protossido d’azoto;
• Anidride carbonica;
• Loro miscele.
Tra i prodotti per la Sanità si contemplano anche:
- gas a uso medico non fisiologicamente attivi, ad esempio per uso invasivo
durante interventi chirurgici o per analisi (in vitro);
- gas il cui impiego non è propriamente farmaceutico ma, comunque,
in ambito sanitario e/o scientifico, rispondenti agli standard di qualità Iso
9000 o altri richiesti dal cliente (elio per risonanza magnetica, gas
di calibrazione eccetera).
La normativa che si applica ai dispositivi medici e ai relativi accessori è il
Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale il 6 marzo 1997, n. 54, Supplemento ordinario): "Attuazione
della direttiva 93/42/Cee, concernente i dispositivi medici”.
Gli accessori sono considerati dispositivi medici a pieno titolo. Nel
decreto e nei suoi allegati, i dispositivi medici e i loro accessori
vengono indicati con termine "dispositivi".
Alcune definizioni
Riportando le definizioni della normativa, si ha:
- dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza
o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software
informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal
fabbricante a essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione,
controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo,
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione
principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico,
ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
- accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato
in modo specifico dal fabbricante a essere utilizzato con un dispositivo
per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso;
- dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da
un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento,
da un apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in combinazione,
destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di
campioni provenienti dal corpo umano al fine di fornire informazioni
sugli stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o anomalia
congenita;
- dispositivo su
misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base
della prescrizione
scritta di un medico debitamente qualificato
e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche
specifiche di progettazione del dispositivo e destinato a essere utilizzato
solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta
anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della
propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi
di fabbricazione continua o in serie, che devono essere successivamente
adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro
utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura;
- dispositivi per
indagini cliniche: un dispositivo destinato a essere messo a disposizione
di
un medico debitamente qualificato per lo svolgimento
di indagini di cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico
umano adeguato. Per l'esecuzione delle indagini cliniche, al medico debitamente
qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale, in base
alla propria qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere
tali indagini;
- fabbricante: la
persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della
fabbricazione,
dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo
in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente
dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona
o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del presente decreto che si
impongono al fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica
che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta
uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione
di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome.
I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale, senza essere
il fabbricante, compone o adatta dispositivi già immessi in commercio
in funzione della loro destinazione a un singolo paziente;
- destinazione: l'utilizzazione
alla quale è destinato il dispositivo
secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio
illustrativo o nel materiale pubblicitario;
- immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso
o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,
in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario,
indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi
a nuovo;
- messa in servizio: prima utilizzazione del dispositivo sul mercato
comunitario secondo la sua destinazione.
Decreto sì
Da un punto di vista applicativo, invece, il decreto stabilisce un preciso
e determinato campo di applicazione e di esclusione.
Quindi, qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza
considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, è soggetto
al decreto, fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo
n. 178 del 1991 e successive modificazioni. Se, tuttavia, un dispositivo
di questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo
e il medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato
a essere utilizzato esclusivamente in tale associazione e non può essere
altrimenti utilizzato, tale prodotto è disciplinato dal Decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. I requisiti
essenziali di cui all'Allegato I del presente decreto si applicano per
quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia del dispositivo.
L’applicazione è, inoltre, prevista in quei dispositivi
comprendenti come parte integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata
separatamente, possa esser considerata un medicinale ai sensi del Decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e possa
avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del
dispositivo.
Decreto no
Il decreto non si applica:
- ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
- ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal Decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
- ai medicinali soggetti al Decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
e successive modificazioni;
- ai prodotti cosmetici disciplinati dal Decreto 11 ottobre 1986, n.
713, e successive modificazioni;
- al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano,
alle cellule ematiche di origine umana o ai dispositivi che, al momento
dell'immissione in commercio, contengono tali prodotti derivati dal sangue,
plasma o cellule;
- a organi, tessuti o cellule di origine umana e a prodotti comprendenti
o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
- a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo
non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti
non vitali derivati da tessuto animale.
Altre aree di non applicazione sono individuabili in settori già ripresi
da altra normativa, quali, per esempio, i casi di seguito illustrati:
- il decreto non si applica ai dispositivi di protezione individuale
disciplinati dal Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, avuto riguardo
della destinazione principale del dispositivo;
- il decreto non si applica nelle materie disciplinate dal Decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230.
Aria compressa
Tra gli impianti che rientrano nell’ambito del Dl 46/97 ci sono
gli impianti di produzione dell’aria compressa. Infatti, l’aria
compressa utilizzata come aria respirabile nel settore medicale deve
sottostare a elevate e particolari esigenze. Curare in modo affidabile
le persone con l’aria respirabile, prodotta da normali compressori
d’aria lubrificati, è un compito di grande responsabilità.
La Pharmacopea Europea ha, quindi, emanato alcuni anni fa delle norme
che regolamentassero la fornitura di questa aria se destinata alla respirazione
umana. Gli impianti per la distribuzione dei gas medicali sono dispositivi
medici destinati a distribuire, all'interno delle strutture sanitarie,
gas medicali quali ossigeno, protossido di azoto e aria medicale. Non
sono normalmente considerati parte del dispositivo medico gli impianti
di fornitura dei gas, che possono essere costituiti da unità di
stoccaggio (bombole, gruppo di contenitori criogenici, evaporatore-riscaldatore)
o da unità di produzione (compressori per la produzione di aria
medicale o miscelatori per aria sintetica).
Gli impianti centralizzati del vuoto sono destinati a fornire, all'interno
delle strutture sanitarie, la pressione negativa utilizzata per l'aspirazione
endocavitaria. Gli impianti sono schematicamente composti da una centrale,
alla quale viene connessa la sorgente del gas o del vuoto, da una rete
di distribuzione e da prese alle quali l'operatore connette appositi
innesti (diversi per ogni gas e non intercambiabili) per prelevare i
gas medicali e per utilizzare la pressione negativa. Le prese possono
essere montate a parete o su travi testa letto nei locali di degenza;
su pareti tecniche e su pensili nelle sale operatorie e nei reparti di
terapia intensiva.
Con questo breve riferimento al settore medicale, si evidenzia come l’aria
compressa - e tutte le componenti che rappresentano l’indotto del
settore - sia fortemente presente anche nel settore sanitario in importanti
momenti della vita del paziente. |