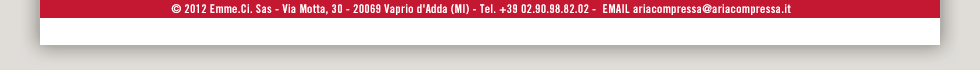Massimo Rivalta - Ingegnere
I danni all'ambiente si sono
costantemente amplificati nel corso degli ultimi decenni. Ogni anno,
negli Stati membri vengono prodotti circa
2 miliardi di tonnellate di rifiuti e questa cifra aumenta del 10% l’anno.
Per il biossido di carbonio, si registrano un aumento delle emissioni
provenienti da fonti domestiche e dai trasporti e un incremento dei consumi
di energie inquinanti.
La qualità della vita della popolazione europea, particolarmente
nelle zone urbane, è soggetta a inquinamento acustico, vandalismo).
La protezione dell’ambiente è, quindi, una delle maggiori
sfide per l’Europa. La Comunità è stata criticata
per aver privilegiato l'economia e lo sviluppo degli scambi commerciali
a spese dell'impatto ambientale. Ora, si riconosce che il modello europeo
di sviluppo non può essere fondato sull'esaurimento delle risorse
naturali e sulla degradazione dell'ambiente.
Le azioni comunitarie
Le prime azioni comunitarie, che hanno avuto inizio nel 1972, nel quadro
di quattro programmi d'azione successivi, erano fondate su un approccio
verticale e settoriale dei problemi ecologici. In questo periodo, la
Comunità ha adottato circa 200 atti legislativi consistenti,
essenzialmente, a limitare l'inquinamento mediante l'introduzione di
norme minime, soprattutto in materia di gestione dei rifiuti, di inquinamento
idrico e di inquinamento atmosferico.
L'introduzione di questo quadro regolamentare non ha permesso di evitare
la degradazione dell'ambiente.
L'intervento comunitario si è sviluppato nel corso degli anni
fino a quando il Trattato sull'Unione Europea non gli ha conferito rango
politico.
Questa evoluzione è proseguita con il Trattato di Amsterdam, con
l'integrazione del principio dello sviluppo sostenibile tra i compiti
della Comunità europea e con l'inserimento, tra le priorità assolute,
del raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente.
Per una maggiore efficacia, il Quinto programma d’azione in materia
ambientale, "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", ha stabilito
i principi di una strategia europea su base volontaria per il periodo
1992-2000, segnando l'inizio di un'azione comunitaria orizzontale, che
tiene conto di tutti i fattori d'inquinamento (industria, energia, turismo,
trasporti, agricoltura).
Questo approccio trasversale della politica ambientale è stato
confermato dalla Commissione in seguito alla comunicazione del 1998 relativa
all'integrazione dell’ambiente nelle politiche dell’Unione,
oltre che dal Consiglio europeo di Vienna (11 e 12 dicembre 1998).
L'integrazione della problematica ambientale nelle altre politiche è diventata
obbligatoria per le istituzioni comunitarie. Da allora, l'aspetto dell'integrazione è stato
oggetto di vari atti comunitari, in particolare nei settori dell'occupazione,
dell'energia, dell'agricoltura, della cooperazione allo sviluppo, del
mercato unico, dell'industria, della pesca, della politica economica
e dei trasporti.
Nel maggio del 2001, è stata adottata una comunicazione sulla
strategia europea per lo sviluppo sostenibile, che istituisce obiettivi
di sviluppo, appunto, sostenibile a lungo termine ed è fondamentalmente
centrata sul cambiamento climatico, sui trasporti, sulla salute e sulle
risorse naturali.
La necessità di un intervento comunitario in materia di responsabilità per
i danni ambientali provocati e in materia di indennizzo è ormai
assodata, dopo l'adozione del Libro bianco sulla responsabilità ambientale
del febbraio 2000.
Il sesto programma
Il Sesto programma d’azione per l’ambiente, in corso di adozione,
definisce le priorità della Comunità europea fino al 2010.
Quattro sono i settori messi in evidenza:
• cambiamento climatico;
•
natura e biodiversità;
• ambiente e salute;
• gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.
Per realizzare tali priorità,
vengono proposte alcune linee d'azione:
• migliorare l'applicazione della legislazione ambientale;
• operare con il mercato e con i cittadini;
• aumentare l'integrazione della componente ambientale nelle altre politiche
comunitarie.
Un elemento di innovazione,
che merita di essere citato, è la
politica integrata dei prodotti, che mira a sviluppare un mercato dei
prodotti più ecologico, rendendoli maggiormente compatibili con
l'ambiente nell'arco dell'intero ciclo di vita.
La gamma degli strumenti ambientali adottati a tale scopo si è ampliata
man mano che si sviluppava la politica dell'ambiente.
Oltre all'adozione di una normativa quadro, che prevede un elevato livello
di protezione dell'ambiente pur garantendo il funzionamento del mercato
interno, la Comunità ha introdotto uno strumento finanziario -
il programma life - e strumenti tecnici:
•
l’etichettatura ecologica;
• il sistema comunitario di ecogestione eaudit;
•
il sistema di valutazione dell’impatto di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
• i criteri per le ispezioni ambientali negli Stati membri.
Il ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente è diventato
sempre più importante nel corso degli anni. Scopo dell'Agenzia è raccogliere
e diffondere informazioni comparabili nel settore dell'ambiente.
Le sue funzioni sono esclusivamente consultive, ma i lavori dell'Agenzia
risultano sempre più determinanti per l'adozione di nuove misure
o per la valutazione dell'impatto delle decisioni già adottate.
Attualmente, l'accento viene posto su una maggiore diversificazione degli
strumenti ambientali, favorendo, in particolare, il ricorso a tasse ambientali
(principio "chi inquina paga"), alla compatibilità ambientale
o ad accordi su base volontaria. Senza un'applicazione effettiva della
legislazione ambientale, non può essere realizzato alcun progresso.
Ciò comporta l'introduzione di misure di incentivazione destinate
agli operatori economici (imprese e consumatori).
La gestione dei rifiuti
Altro fattore molto importante è la Gestione dei rifiuti.
La politica comunitaria, in tale materia, è basata su tre strategie
complementari:
• prevenire la creazione di rifiuti migliorando la concezione dei prodotti;
• promuovere il riciclaggio e la riutilizzazione dei rifiuti;
• ridurre l'inquinamento provocato dall'incenerimento dei rifiuti.
La Comunità ha voluto puntare sulla responsabilità del
produttore.
Ad esempio, in materia di veicoli fuori uso, la proposta di direttiva
del 1997 prevede l'instaurazione di un sistema riguardante la loro raccolta;
la direttiva del settembre 2000 stabilisce l'instaurazione di un sistema
di raccolta dei veicoli a fine vita a carico del produttore. Nella stessa
ottica, sono in via di adozione due proposte di direttive riguardanti,
rispettivamente, i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
e la limitazione dell'impiego di alcune sostanze pericolose in tali apparecchiature.
Su scala internazionale, questo approccio è stato scelto anche
in occasione della prima Conferenza delle parti della convenzione Ospar
per la protezione dell’ambiente nell’Atlantico nordorientale,
dove si trattava, tra l'altro, di negoziare lo smantellamento e l’eliminazione
degli impianti off-shore di petrolio e gas.
Le parti della convenzione hanno, infatti, adottato la posizione sostenuta
dalla Commissione europea basata sul principio di vietare lo smaltimento
in mare di tali impianti, mentre i costi connessi allo smantellamento
e all'eliminazione sono a carico dei proprietari degli impianti stessi.
L'Unione europea ha definito i flussi di rifiuti da prendere in considerazione
in via prioritaria. Ha, inoltre, legiferato in materia di rifiuti di
imballaggio, di pile e di oli.
Anche le diverse soluzioni per il trattamento dei rifiuti, come la messa
in discarica e l'incenerimento, sono state oggetto di misure comunitarie.
La Comunità è parte contraente della Convenzione sul controllo
dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione
(Convenzione di Basilea), cui aderiscono 100 Paesi. Essa ha già ratificato
un emendamento della convenzione che vieta le esportazioni di rifiuti
pericolosi dei Paesi Ocse, della Comunità e del Liechtenstein
verso i Paesi non membri dell'Ocse, siano esse a fini di eliminazione,
riciclaggio o valorizzazione.
Inquinamento acustico
Nel settore dell’inquinamento acustico, per molto tempo la strategia
comunitaria consisteva essenzialmente nello stabilire livelli minimi
di rumore per talune macchine: tosaerba, motocicli o, più recentemente,
aeromoili e macchine utilizzate all’aperto.
Nel quadro del Libro verde del 1996, la Commissione ha proposto di estendere
questa strategia riducendo le emissioni alla fonte, promuovendo gli scambi
di informazioni e rendendo più coerenti i programmi di lotta contro
il rumore.
Per dare nuovo impulso alla lotta contro il rumore, nel 2000 è stata
lanciata una proposta di direttiva che definisce un approccio comunitario
in materia di gestione e di valutazione del rumore ambiente, con l'obiettivo
di proteggere la salute dei cittadini.
Inquinamento idrico
L’inquinamento idrico fa anch’esso parte degli interventi
comunitari.
Gli Stati membri hanno adottato numerose direttive per fissare norme
di qualità dell'acqua (per l’acqua potabile, le acque di
balneazione, quelle destinate alla piscicoltura e alla molluschicoltura).
Negli anni '80 e nei primi anni '90, le misure comunitarie si sono basate
maggiormente sul principio dei valori limite di emissione, come dimostrano
i due esempi del trattamento delle acque reflue urbane e della lotta
all’inquinamento idrico provocato dai nitrati.
A partire dal 1995, la Comunità ha iniziato ad adottare un approccio
più globale alla gestione delle acque, sfociato nell'adozione
della direttiva quadro relativa all’azione comunitaria in materia
di acque, che intende promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse
idriche e garantire la coerenza delle politiche del settore.
La Comunità è parte contraente di varie convenzioni internazionali
miranti a proteggere l'ambiente marino quali:
•
la Convenzione Ospar, già menzionata;
• la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo
(decisione 77/585/Cee del Consiglio, Gazzetta ufficiale L. 240 del 19/9/1977);
• la Convenzione di Parigi per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico
nordorientale.
Altre convenzioni intendono
proteggere i corsi d'acqua, tra cui ricordiamo le più importanti:
• Convenzione di Helsinki sui corsi d'acqua transfrontalieri e sui laghi
internazionali;
• Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzo sostenibile
del Danubio (Gazzetta ufficiale L. 342 del 12/12/1997);
• Convenzione per la protezione del Reno.
Inquinamento atmosferico
Il miglioramento della qualità dell'aria è una priorità su
scala mondiale. Una riduzione significativa dell'inquinamento atmosferico,
responsabile del riscaldamento del pianeta, richiede la combinazione
di misure nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni di
gas inquinanti.
In base a questo principio, sono stati adottati la Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) e il Protocollo
di Kyoto (1997).
Le parti si sono impegnate a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni
di gas a effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990.
L'Unione europea ha, in varie occasioni, riaffermato il proprio deciso
impegno nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
In occasione del Consiglio europeo di Stoccolma (giugno 2001), l'Unione
ha sottolineato la sua preoccupazione di fronte al fatto che alcuni Paesi,
in particolare gli Stati Uniti, rimettessero in questione il protocollo.
Durante la Conferenza delle Parti (Cop 6 bis) di Bonn (19-23 luglio 2001),
le parti firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici hanno trovato un accordo sulle modalità di
attuazione del Protocollo di Kyoto. Infine, alla conferenza di Marrakech
(Cop 7, dal 29 ottobre al 9 novembre 2001), le parti hanno raggiunto
un accordo che traduce in un testo giuridicamente vincolante le modalità di
attuazione del Protocollo di Kyoto.
Per cercare di conseguire l'obiettivo che si è fissata nell'ambito
del Protocollo di Kyoto, la Comunità ha adottato un programma
sui cambiamenti climatici e comunicazione sulla sua attuazione.
Tale programma individua, in particolare, nei settori dell'energia, dei
trasporti, dell'industria e della ricerca, i campi di azione prioritari.
La Commissione ha, inoltre, pubblicato un Libro verde sullo scambio dei
diritti di emissione di gas a effetto serra nell'Unione europea.
La Comunità è anche parte contraente della Convenzione
di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza,
oltre che dei protocolli internazionali sulle sostanze acidificanti che
integrano la convenzione.
La legislazione comunitaria, in questo settore, ha come obiettivo prioritario
la lotta contro le emissioni prodotte dalle attività industriali
e dai veicoli di trasporto. In materia di trasporti, la strategia è basata
su diversi elementi:
• una riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli (marmitta catalitica,
revisione periodica);
• una diminuzione dei consumi delle autovetture (in collaborazione con
i costruttori automobilistici);
• la promozione di veicoli puliti (misure fiscali).
Strategie mirate
Per migliorare la qualità dell'aria, nel maggio 2001 è stata
adottata una strategia globale, mentre varie direttive sono in via di
adozione o sono già state adottate.
In particolare, si tratta di ridurre la concentrazione dell’ozono
nell’aria ambiente, di fissare limiti nazionali di emissione per
altri inquinanti atmosferici e di limitare le emissioni inquinanti dei
grandi impianti di combustione.
Nell’ambito degli interventi per la protezione della natura in
Europa, bisogna considerare che circa 1000 specie vegetali e oltre 150
specie di uccelli sono gravemente minacciate o sono in via di estinzione.
Per combattere questa situazione, la legislazione comunitaria ha adottato
diverse disposizioni per la protezione della vita selvatica (protezione
di talune specie come gli uccelli, le foche, i cetacei e i delfini) e
degli habitat naturali (protezione delle foreste e dei corsi d'acqua).
Più recentemente, la Comunità ha pubblicato dei piani di
azione in favore della biodiversità nel settore delle risorse
naturali, dell’agricoltura, della pesca, dell’aiuto allo
sviluppo e della cooperazione economica.
La Comunità, anche in questo caso, è parte contraente di
diverse convenzioni, in particolare della Convenzione di Berna sulla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici
della fauna selvatica e della Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica.
Protezione civile
Le società moderne sono sempre più esposte a rischi di
ogni genere: naturali, tecnologici, ambientali.
Per contribuire alla prevenzione di questi rischi e prepararsi ad affrontare
le situazioni di emergenza che ne derivano, la Comunità ha elaborato
un programma d’azione comunitario per la protezione civile, prolungato
fino al 2004, e ha emanato una direttiva sulla prevenzione dei rischi
industriali rilevanti. La Comunità ha inoltre sottoscritto la
Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli
incidenti industriali.
Per quanto concerne il settore nucleare, la Comunità ha elaborato
una serie di disposizioni come le direttive sulla radioprotezione e un
piano d'azione per la gestione dei residui radioattivi. E’ stata,
inoltre, istituita una cooperazione tecnica per la sicurezza degli impianti.
A tutti i rischi descritti si sono aggiunti gli organismi geneticamente
modificati (Ogm).
Per far fronte alle potenziali implicazioni che gli Ogm possono avere
per l'ambiente, la Comunità ha adottato due direttive: una relativa
all'emissione nell'ambiente degli Ogm e l'altra relativa all'impiego
confinato di tali organismi.
I Paesi “candidati”
Purtroppo, nei Paesi dell’Europa centrale e orientale (Peco) la
situazione nel settore ambientale è attualmente molto degradata.
L'ampliamento dell'Unione ai Peco comporta, sul piano ambientale, una
sfida la cui ampiezza non può essere paragonata alle adesioni
precedenti.
I Paesi candidati all'adesione dovranno recepire la normativa comunitaria
consolidata in campo ambientale nella loro legislazione. Questo processo
potrà essere realizzato solo a lungo termine.
Sono gli stessi Paesi candidati che dovranno mobilitare le risorse necessarie
all'accoglimento della normativa consolidata in campo ambientale, ma
la Comunità e gli Stati membri hanno un ruolo importante da svolgere
tramite i programmi bilaterali.
La Commissione è intervenuta nel settore dell'ambiente, in particolare
con il programma Phare e favorendo la partecipazione dei Paesi candidati
al programma Life.
L'aiuto comunitario nel settore dell'ambiente nella fase di preadesione è aumentato
considerevolmente dal 2000, grazie all'intervento dello strumento strutturale
di preadesione (Ispa) che concerne i settori dell'ambiente e dei trasporti.
I Paesi candidati all'adesione hanno concluso accordi con la Comunità europea
per entrare a far parte dell’Agenzia europea dell’ambiente
e della Rete europea d'informazione e di osservazione ambientale. Tale
partecipazione è diventata effettiva nel corso del 2001.
Nell’ambito della Cooperazione internazionale, la Comunità europea
prevede, tra gli obiettivi della politica ambientale della Comunità,
la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere
i problemi ambientali a livello regionale e mondiale.
A tale scopo, il trattato prevede la cooperazione della Comunità con
i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti.
La Comunità è, pertanto, parte contraente di convenzioni
internazionali per la protezione dell'ambiente fin dagli anni '70. Attualmente, è parte
contraente di più di una trentina di convenzioni e accordi in
materia ambientale e partecipa attivamente ai negoziati per l'adozione
di tali strumenti, nell'ambito delle sue competenze. La Comunità partecipa
anche, in genere come osservatore, alle attività e ai negoziati
nel quadro di organismi o programmi internazionali, in particolare sotto
l'egida delle Nazioni Unite.
In alcuni casi, queste convenzioni sono di portata globale, in altri
di portata regionale.
Convenzioni globali
Tra le convenzioni globali, particolare menzione meritano la Convenzione
di Vienna per la protezione dello strato di ozono (Gazzetta ufficiale
L. 297 del 31/10/1988) e il relativo Protocollo di Montreal riguardante
le sostanze che riducono lo strato d'ozono (Gazzetta ufficiale L. 297
del 31/10/1988), le Convenzioni delle Nazioni Unite sulla diversità biologica
e sui cambiamenti climatici (Gazzetta ufficiale L: 33 del 7/2/1994),
la Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione e sull'accesso
alla giustizia in materia ambientale. La Comunità ha anche firmato
il Protocollo di Kyoto che prevede misure e obblighi volti a ridurre
le emissioni di gas a effetto serra.
Un quadro sicuramente interessante, quello descritto, che offre vari
spunti di riflessione sulla salute e sulla tutela del nostro pianeta
e sull’impegno della Comunità Europea in particolare. |